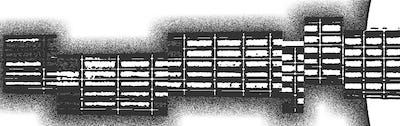Scatola di montaggio: la canzone petrarchesca
È estate ed è tempo di canzoni. Si potrebbero fare degli studi sulle caratteristiche dei tormentoni estivi, e anche chiedersi quale sia la soglia fisiologica al di là della quale il corpo umano non li sopporta più, ma non è questo il luogo adatto. I tormentoni estivi sono canzoni nel senso che vengono cantati, e quanto alla loro nefanda insostenibilità acustica ed emotiva mi immagino Umberto Eco che solleva il dito e mi ammonisce dicendo che Il fatto che la canzone di consumo possa attirarmi grazie a una imperiosa agogica del ritmo, che interviene a dosare e a dirigere i miei riflessi, può costituire un valore indispensabile, che tutte le società sane hanno perseguito e che costituisce il normale canale di sfogo per una serie di tensioni.
È che La musica di consumo è contenuto in Apocalittici e integrati che è del 1964, e Dio sarebbe morto nei dischi dell’estate già l’anno dopo, e la vacuità ideologica del tormentone estivo come fonte di intrattenimento e distrazione della massa dei consumatori doveva ancora incontrare la potenza di fuoco del tardo capitalismo del There is no alternative, per cui allo spirito di Umberto Eco ora dovrebbe affiancarsi quello di Mark Fisher che mi direbbe semmai di cercare la catarsi politica nella scena rave e io qui ho difficoltà perché in genere sono una persona asociale che va a letto presto.
Tralasciando le potenzialità semantiche e sociali dei tormentoni estivi, Sillabe oggi quindi parla della canzone intesa come classica forma metrica della poesia italiana.
La canzone è una forma antica di poesia lirica: trae origine da un modello provenzale e viene canonizzata fin dai tempi di Petrarca. In seguito ci saranno autori che cercheranno di svincolarsi dalla forma così costituita, ma in questa puntata di Sillabe ci si occupa espressamente della canzone petrarchesca, ricalcandone la struttura.
Al solito, si smonta e si rimonta.
La canzone si compone di un numero indeterminato di stanze, ciascuna delle quali a sua volta conta un numero indeterminato di versi, che sono settenari o endecasillabi.
La stanza si compone di due parti, detti fronte e sirima. La fronte contiene due o più piedi, che sono metricamente uguali; anche la sirima può essere composta di due parti uguali che invece si chiamano volte. Le rime della prima stanza si ripetono uguali nelle stanze successive.
Il passaggio tra la fronte e la sirima si chiama diesi o chiave e spesso rima con l’ultimo verso della fronte.
Poiché la canzone nasce come tradizione orale, i poeti si inventavano degli espedienti mnemonici per risalire senza difficoltà all’intero testo, concatenando le rime e richiamando nella sirima alcune rime della fronte.
La canzone poi generalmente si chiude con un congedo che il poeta utilizza per inviarla al destinatario, e in cui sovente si rivolge alla canzone stessa come se fosse un interlocutore.
Lo farà anche Lucio Dalla (Canzone / cercala se puoi / dille che non mi lasci mai).
La canzone, infine, era accompagnata dalla musica. Qui ci limiteremo al testo, se no c’è il pericolo che diventi un tormentone estivo. Per abbassare ulteriormente il rischio anche l’argomento sarà poco adatto all’atmosfera balneare: siccome fa caldo, ecco dunque una canzone petrarchesca in cinque stanze che parla degli organismi estremofili, ossia quegli organismi - quasi sempre batteri - che si sono adattati a vivere in condizioni estreme per quanto riguarda la temperatura, la pressione, l’acidità o l’alcalinità, insomma per quanto riguarda tutti i parametri fisici, chimici e biologici in cui si è evoluto il resto della vita sulla Terra. Lo studio degli estremofili dice molte cose interessanti sulla vita, sulle possibilità della sua genesi e della sua riuscita e, come spesso accade quando si indaga il comportamento di ciò che è tanto lontano dai nostri canoni, ci dice per contrasto e definizione anche molte cose interessanti su noi stessi.
Lo schema metrico per le stanze è: aBbCcDdAaBEeBFA
La struttura del congedo è: aBCcBDA
Che strana, l’esistenza.
E questa vita, insomma, dove va?
Vagheggia e se ne sta
lì dove tutti quanti respiriamo
e, vivi, poi moriamo,
nel mondo che crediamo conosciuto
e spesso resta muto,
alla ricerca di un’incongruenza.
Ci salva la presenza
di forme nuove e diversa realtà
che crea, multiforme dentro i mari,
increduli scenari
di ciò che vive d’altra verità,
e noi saremo forse un giorno pronti
a farne smisurata conoscenza.
Ho visto questi ambienti
sotto le radiazioni ionizzanti,
calori soffocanti,
e acidi fatali, in mezzo al gelo,
ovunque sotto il cielo.
Minuscoli imperterriti organismi
ciascuno coi suoi crismi
a dir di sé tra increduli viventi,
per forza resistenti:
racconti d’una vita che va avanti
e celebra impossibile se stessa
e fa di sé promessa
d’aver riempito universi vacanti,
stranieri a questo nostro ancor per poco,
solcando terre e mari e continenti.
Ho visto vite estreme
felici e stemperate nei deserti,
in spazi chiusi e aperti,
nel sale screpolato dentro un golfo,
nutrite dallo zolfo,
lì dove non potremmo stare noi
a definirci eroi
con questa nostra bocca che poi geme
e le parole preme
per dire i nostri comuni sconcerti.
Eppure è vita, solenne e severa,
che vive e quindi spera,
e lascia al mondo continui reperti
di ciò ch’è stato, di ciò che sarà,
e striscia, bolle, sprizza, chiama e freme.
Allora mi domando
com’è che siamo fatti e poi perché
esiste quel che c’è,
si evolve e muta e trepida e resiste,
o dovrei dire insiste,
e si regala ancora un altro ballo
intriso nel metallo.
E nasce, e vive, e muore, continuando
e gioca di rimando
con ciò ch’è tanto diverso da me:
cos’è che posso allora dire vita,
com’è ch’è definita,
in quale compiutezza dice se
qualcosa nasce e poi muore, alla fine,
o vivrà ancora e non so fino a quando.
Altri pianeti guardo,
le basi ignote d’una biologia
ch’è quasi una follia,
e cerco ancora un organismo estremo,
un argine supremo
a quel che posso dire vita
comunque concepita,
qualcosa che possieda per traguardo
un vivere bastardo
rispetto a quel che sento cosa mia;
aspri tormenti d’un mondo reale
ch’è vero e marginale
inscritto in un’immensa ecologia
in cui ciò ch’è diverso non è detto
che debba essere ancora bugiardo.
Cantami la famiglia,
canzone, della vita in altre sponde,
d’incauti limiti ostili ed erranti
sospesi ai loro incanti,
che alle mie domande non risponde:
e scrivi in quelle pieghe un universo
in cui si stringa al dubbio meraviglia.
Una prosa è una prosa è una prosa: Instagram come volontà e rappresentazione
Finto dialogo platonico scritto parecchi anni fa, quando il social dei cuoricini aveva cominciato a dispiegare le sue potenzialità, era appena stato comprato da Facebook, ben prima che cercasse di intercettare le dinamiche di TikTok, e io mi interrogavo sull’improvviso gigantismo del ruolo dell’immagine associata alla gratifica del like. Socrate qui parla con il suo giovane amico Mimesio. Il dialogo è pedantissimo e un po’ scemo, ma ci sono rimasta affezionata. Potete trovarlo qui.
Mimesio: […] Rimpinzata di hashtags e condivisa in rete, si celebra la propria immagine come merce di consumo, il compimento dell’estraniazione estetizzante, altro che imitazione della natura, o Socrate. L’altro giorno sono rimasto due ore a guardare immagini quadrate di bizzarri poeti giambici, ornati di pesanti monili d’oro e attorniati dalle loro etère; la veste delle fanciulle appariva barbaramente strappata...
Socrate: Dicono si tratti di rapper, o Mimesio. Sono autori di una derivazione della lirica monodica, cultori della poesia giambica, interpreti di un genere che peraltro ha avuto anche momenti di funzionalità politica e sociale.
Mimesio: Io bado alle immagini, Socrate, ché di queste si parla. L’estetica che ne esce fuori è tale: se consideriamo l’immagine filtrata in Instagram come processo di autosviluppo formativo dello spirito e come sua liberazione (Bildung, si sarebbe detto un tempo), e se lo scopo della fotografia filtrata e pubblicata è, in quanto pretesa opera d’arte, quello di rivelare la verità sotto forma di configurazione artistica sensibile, se ne deduce che la manifestazione dello spirito che pensa se stesso ha molto a che fare con: la quotidianità della propria faccia, dei propri piedi, della propria ebbrezza alcolica (ma privata dello scandalo, quindi svuotata), del proprio cibo di riferimento, del proprio specchio del bagno, del proprio tramonto e del proprio amore - oltre che, ovviamente, trattandosi di internet, del proprio animale domestico, meglio se debitamente antropomorfizzato.
Figure: un distico per l’estate
Distico in endecasillabi per manifestare il mio dispetto nei confronti del caldo estivo.
Altre cose sul blog: Un’altra versione