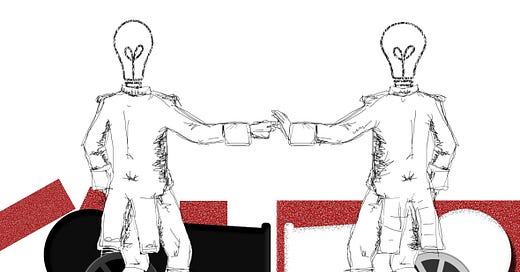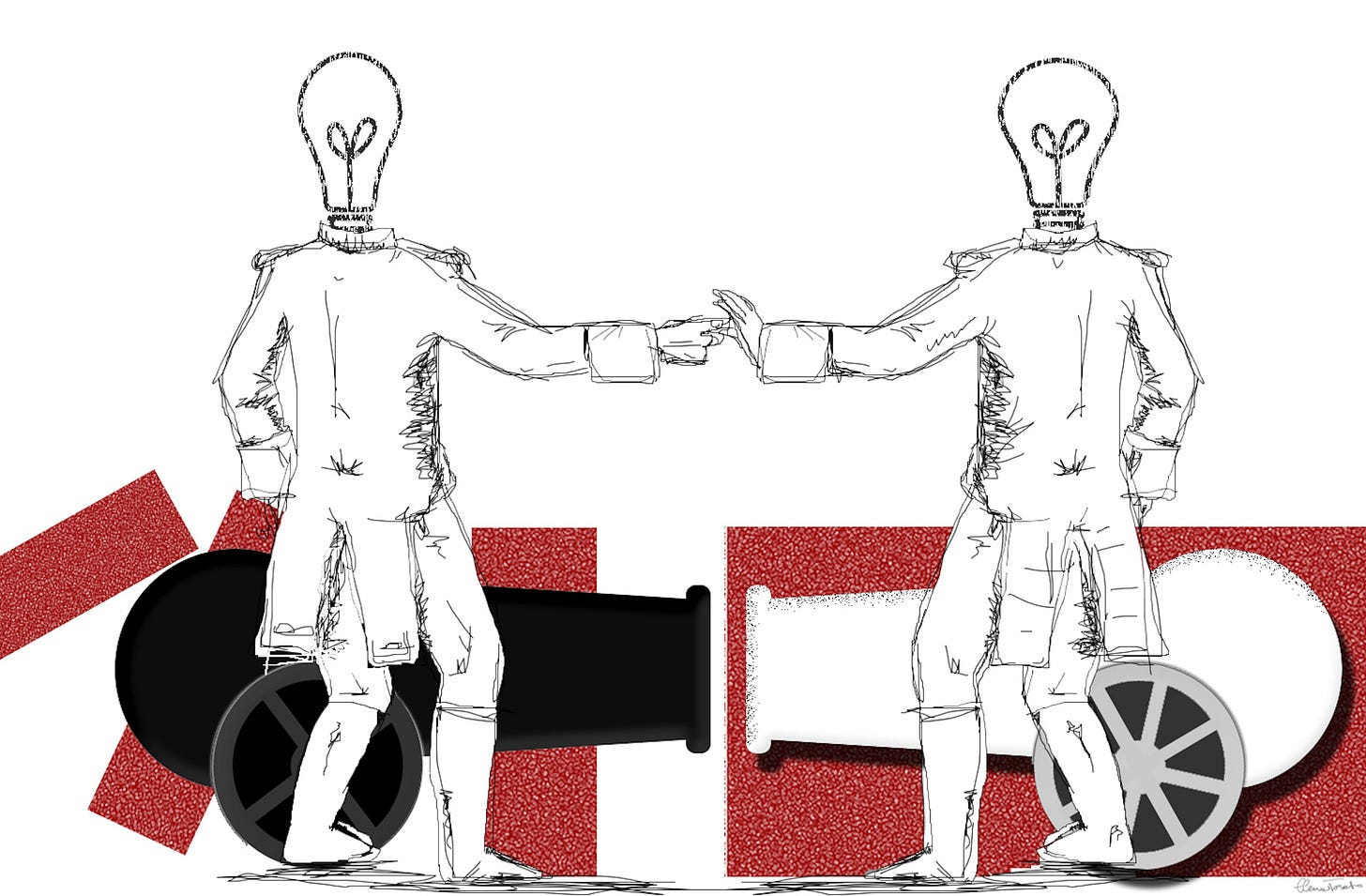C’è stato un tempo in cui la scrittura delle poesie era demandata a professionisti che lavoravano per un committente, pubblico o sufficientemente altolocato1. Il fenomeno si riscontra in molte società: dai poeti di corte di Federico II di Svevia, ai poeti delle corti persiane, passando attraverso i secoli e i confini da un Pindaro che viaggiava da una famiglia importante all’altra all’analoga sorte toccata ai poeti indiani e a quelli celti, che non di rado si tramandavano il mestiere di padre in figlio.
Il poeta poteva dipendere da un mecenate (appunto, come Orazio o Virgilio beneficiarono della liberalità del Gaio Clinio Mecenate da cui il termine deriva) o da un sovrano; in quest’ultimo caso la loro libertà poetica era più o meno ampia, a seconda delle inclinazioni di chi pagava loro le spese, ma ci si poteva aspettare che prevedesse in cambio una dose anche cospicua di propaganda.
Anche la forma della poesia veniva influenzata dal ruolo sociale che essa doveva avere. La puntata di questa settimana si occupa a tal proposito del sirventese, e del suo più noto esponente che fu Bertran de Born.
Scatola di montaggio: il sirventese
Il sirventese è una poesia d’occasione, scritta cioè per determinati scopi immediatamente riconoscibili: servire un signore, o una causa. Nasce nella poesia provenzale e il nome viene dal sirven, il servitore del signore. Era una poesia cantata; di alcuni componimenti abbiamo ancora la musica che li accompagnava.
Il principale esponente del genere fu Bertran de Born, attivo in Francia nella seconda metà del XII secolo. L’utilizzo del mezzo poetico fatto da Bertran è finalizzato all’espressione delle idee, dei sentimenti e delle paure dell’aristocrazia dell’epoca, alla definizione di un’etica cavalleresca che possa essere messa in relazione sia alla guerra che al comportamento da seguire in tempi di pace. È una poesia in cui è chiara l’appartenenza alla classe sociale, e chiara la rivendicazione delle qualità morali che si ritenevano appannaggio di tale classe. Le virtù da perseguire sono fieramente descritte, ai limiti dell’enfasi: il coraggio in battaglia, la generosità nei confronti dei sottoposti e degli amici, lo sprezzo per il calcolo materiale, o per il pericolo. La guerra funziona da catalizzatore per le qualità morali, eppure la poesia è ambientata in tempo di pace, o comunque fuori dall’immediata contingenza dei campi di battaglia. Da ciò si ricava una sorta di nostalgia per ciò che la guerra può portare in termini di, oggi diremmo, semplificazione dell’esistente: il netto confine tra buoni e cattivi (almeno per chi ci è dentro), l’esaltazione della forza e del coraggio, l’apologia della morte eroica che perfonde di gloria il vincitore ed esalta il martirio del vinto. Questi valori si riflettono poi nella vita di tutti i giorni: l’uomo di guerra trasferisce le sue qualità nel suo essere uomo sociale e amante delle donne. Lontano dai campi di battaglia, Bertran scrive e manifesta la sua frustrazione. E tutto questo è il sirventese2.
Bertran de Born ebbe epigoni attivi in tutta Europa. Da ricordare la sua corrispondenza con Arnaut Daniel, che abbiamo già citato nelle puntate 18 e 19 sulla sestina lirica, e con il quale c’era stima reciproca. La sua eco si spinge fino al XX secolo, quando finì nelle mani di Ezra Pound, che lo usò come modello per alcune composizioni. Dante lo cita tre volte: due volte per fargli i complimenti come autore, nel De vulgari eloquentia e nel Convivio, e una volta, perché Dante è pur sempre Dante, nel canto 28 dell’Inferno, in cui il malcapitato Bertran finisce nella nona bolgia tra i seminatori di discordia.
Veniamo ora alla produzione propria, che è il senso per cui esiste la Scatola di Montaggio. Dal punto di vista metrico, il sirventese non presenta particolari difficoltà. Si tratta di una struttura a strofe in cui ciascuna strofa ha versi isosillabici e rime a schema fisso, che può consistere di una sola uscita, di lunghe ripetizioni come AAAABBBB o di incroci di vario tipo, come ABABBBCCB, AABAAB.
Per quanto riguarda il contenuto, ho scelto un’ambientazione relativamente contemporanea in cui trasferire i modelli comportamentali enfatizzati dai sirventesi originali: cavalieri non ce ne sono più, e riportarne l’etica di pari passo la farebbe sembrare una smargiassata anacronistica. Ma molte cose si possono adattare, per cui ho pensato che mettere il sirventese al servizio del Dottor Stranamore potesse funzionare, a modo suo. Vediamo. Utilizzeremo dei settenari e uno schema AABBAB ripetuto.
Io canto questa rima
nell’agio d’aver stima
di mar, di cielo e terra.
Al cuore mio si serra
ciò che giammai fu prima
l’ardore della guerra.
S’è detto ch’è pazzia
davvero questa mia
indebita ossessione
di dare la ragione
all’arma purchessia.
Lo dicon le persone!
Le loro sole pene
sono di viver bene,
ignare di quel puro
mortale scontro duro
che porta in sé l’igiene
di un nobile futuro.
Il mondo vada e muoia!
Io me ne faccio boia.
Rinascerà di nuovo,
sgusciante come un uovo
lucente di una gioia
ch’io solo, adesso, provo.
L’amor mai morto e vecchio
nel quale mi rispecchio
d’un mondo infine sano
in ogni fato umano
s’appoggia all’apparecchio
su cui pongo la mano.
E volerà la bomba
con arte di palomba
a dire la sua pace:
laggiù ciascuno giace
nella sua mera tomba
e il pavido ne tace.
Una prosa è una prosa è una prosa
Decimo capitolo da Manuale di conversazione. Amor che al cor gentil ratto s’apprende. Irene Cardin e l’amore. Tocca a tutti parlare d’amore, no? E, se va bene, praticarlo.
A questo punto il lettore del manuale potrà chiedersi in che modo io abbia affrontato le conversazioni nel loro contesto umano principale, che non è quello dell’agone dialettico e politico ma ovviamente quello sentimentale; insomma si starà chiedendo, siccome la pruriginosità dei lettori travalica sempre la capacità degli autori di nascondersi, e supera anche quell’indefinibile commistione tra vanità e pudore che intride i testi scritti, se nella mia vita amorosa ci si sia confinati a vivere scene strampalate come quella cui ho accennato all’inizio del libro, la mia uscita serale con il giocatore di scacchi.
Be’, la risposta è no. Ho avuto, come accennavo in quell’occasione, normali esigenze affettive, normali compulsioni fisiche, e tutti i comunissimi arzigogoli dell’adolescenza, sospiri e aspettative di una persona fra le tante.
Ecco dunque che pongo in essere il manifestarsi della mia acribia sentimentale e mi metto a raccontare, anche se la rievocazione inattuale dei propri passati amori significa abdicare alla prevalenza di pulsioni irrazionali e commovente fiducia e spiegazioni raccogliticce, ben che vada statistiche, per quanto si possa fare della statistica con dei numeri così piccoli qual è il numero delle mie relazioni amorose degne di nota, vale a dire quelle che abbiano avuto un riscontro benché minimo nella realtà dei fatti e non siano rimaste confinate, nella scelta del loro oggetto di interesse, alle mie costruzioni mentali. […]Resa acuta da anni di solitudine la mia immaginazione fremeva, appagandosi di tutte le variazioni sul tema che riusciva a concepire, sfruculiando fino alla noia questo o quel dettaglio, o divagando per inventarsi orizzonti sconosciuti da cui trarre eccitazione e mistero, piantonando le immagini che si costruiva fino ad avere la sicurezza di padroneggiarne qualsiasi risvolto, e modellando infine una realtà parallela che nasceva come la media pesata di tutte le fantasie contingenti. Nel supposto dialogo del cuore con se stesso, nell’adolescenza e prima, avrei dovuto decifrare quali erano i suoi riferimenti culturali, giacché era da escludersi che da solo fosse in grado di leggersi dentro. Di mio sapevo poche cose: che non amavo il contatto fisico leggero, come lo sfioramento o la stretta di mano o la pacca incerta sulla spalla, che invece apprezzavo gli abbracci, ma solo a patto che fossero fatti con una ben precisa e uniforme pressione delle braccia sul corpo, e che provenissero da persone di comprovata affidabilità che non mi avessero cioè mentito in passato, e che non volessero aggiungere all’abbraccio baci umidi sulle guance, il cui rumore a risucchio mi atterriva al sol pensiero. Stanti queste premesse, la prima volta che apparve Lui avevo tutte le carte in regola per combinare poco o nulla.
Quartine al bar
In realtà il caffè che bevo è un pretesto: mi siedo ai tavolini del bar per guardare le persone.
Il vetro filtra chiaro, e caramella
il sole che fa luce, a mezzodì,
e quasi scorda d’essere una stella,
e guarda noi che passiamo così:
c’è la signora del mercoledì
che beve un cappuccino alla cannella
e dice al mondo intero “sono qui,
e sono vecchia, ho fame, e sono bella.”
Libri miei
Tutti a disposizione a questo indirizzo.
La tendenza che oggi va per la maggiore, cioè inseguire i gusti del pubblico e dei pari in quanto l’unico metro con cui si valuta il valore di un’opera è rapportato al numero di vendite o di interazioni sui social, che sono a loro volta fenomeni legati all’appartenenza a una determinata cerchia sociale, non garantisce in sé una maggiore libertà compositiva. In compenso garantisce quasi sempre introiti più bassi e un obbligo de facto a restare nella condizione di dilettante.
Meno male che siamo nel XII secolo e non nella modernità, se no poteva servire da spunto a qualche generale privo del senso del ridicolo per scriverci un libro in prosa.